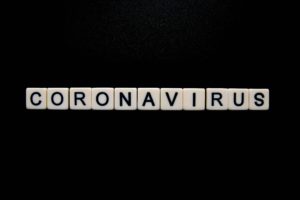Che cosa hanno in comune un’università non statale e un doposcuola in quartieri degradati? Un centro fitness e un’organizzazione sportiva per disabili? Un pub e una mensa per i poveri? Una clinica religiosa e un’associazione di volontariato sanitario? A tutti appare ovvio che trattasi di organizzazioni encomiabili perché non distribuiscono utili, favoriscono la coesione sociale e rispondono ai bisogni dei più deboli. E però il loro contributo all’interesse generale non è scontato né facilmente misurabile.
Che cosa hanno in comune un’università non statale e un doposcuola in quartieri degradati? Un centro fitness e un’organizzazione sportiva per disabili? Un pub e una mensa per i poveri? Una clinica religiosa e un’associazione di volontariato sanitario? A tutti appare ovvio che trattasi di organizzazioni encomiabili perché non distribuiscono utili, favoriscono la coesione sociale e rispondono ai bisogni dei più deboli. E però il loro contributo all’interesse generale non è scontato né facilmente misurabile.
Una prospettiva critica su questa realtà, sempre più importante ma poco e male conosciuta, viene fornita da Giovanni Moro, sociologo politico, docente nelle università di Roma Tre e Gregoriana e presidente di Fondaca, un think tank europeo costituito nel 2001 che si occupa di temi connessi alla cittadinanza attiva.
Una teoria difettosa, secondo Moro, ha unito in un insieme magmatico iniziative della massima utilità sociale, altre genericamente positive e altre che sfruttano l’alone di benemerenza di cui questo insieme gode. Il titolo è volutamente provocatorio, ma questo libro non è contro il non profit, se con questo termine si fa riferimento a cittadini che agiscono pubblicamente per tutelare diritti, curare beni comuni o aiutare persone in difficoltà. Esso è invece contro quel non profit che assume comportamenti stridenti con il senso comune che attribuisce al c.d. terzo settore virtù intrinseche. Per esempio, “vestire” un ristorante da associazione culturale o dichiarare non profit una struttura sanitaria o educativa accessibile solo ai ricchi sono patologie intrinseche alla concettualizzazione del non profit e non un difetto morale dei suoi protagonisti.
La tesi del libro è che il settore non profit sia stato “inventato” tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Questo paradigma ha dato un valore assoluto ad attività di modesta importanza, utilizzando anche l’impegno di molte persone per giustificare l’esistenza di forme di imprenditorìa che, in alcuni casi, sono davvero sociali ma in numerosi altri non lo sono. Secondo Moro, non si può più continuare a dare per scontato che il non profit sia un fatto naturale produttivo di un alto valore sociale. La parola chiave ora è distinguere e per poterne uscire occorre, da un lato, destrutturare questo insieme spurio riconoscendovi realtà operative completamente differenti fra loro e, dall’altro, attribuire diversi gradi di utilità sociale alle attività (e non alle strutture che le realizzano). L’A. è consapevole che, al di là del titolo, il libro costituisce una provocazione perché parlare male del non profit è un po’ come sparare sulla Croce Rossa. Pur nella sua durezza e nel suo carattere assertivo, esso è però animato da uno spirito costruttivo.
Nella prima metà degli anni ’90 del secolo scorso, una ricerca comparativa su tredici paesi, tra i quali l’Italia, veniva promossa dalla Johns Hopkins University di Baltimora per colmare il divario di conoscenza sulle tante scuole, ospedali, asili nido, case di cura, ricoveri per senza fissa dimora, gruppi ambientalisti ed altri operanti sul territorio. C’era in effetti una crescente insoddisfazione per la inefficienza/inefficacia dello Stato nel gestire le attività legate al benessere e allo sviluppo sociale. Tradizionalmente la vita sociale ed economica era basata su due pilastri: lo Stato e il mercato, il settore pubblico e quello privato. Operava però di fatto un terzo insieme di organizzazioni private nella forma ma pubbliche nello scopo, cioè entità non governative ma che non perseguivano il profitto per i loro azionisti o proprietari.
La definizione messa a punto per realizzare questa imponente ricerca fissava le sette caratteristiche che una struttura doveva avere per rientrare nel campo della ricerca: formalità, natura privata, non distribuzione di profitti, autogoverno, presenza di volontari, non religiosa, non politica. A conclusione del loro lavoro, i ricercatori proposero una classifica internazionale delle Non Profit Organizations che ha conosciuto una notevole fortuna, in quanto è stata poi utilizzata dalle Nazioni Unite. Così, il paradigma del non profit come un tutto omogeneo si è largamente affermato su scala mondiale ed è tuttora utilizzato dagli istituti nazionali di statistica, compreso l’Istat. Ma al di là dei complimenti dovuti ai ricercatori di Baltimora – che hanno imposto all’attenzione internazionale un insieme di entità che erano state fino a quel momento sottovalutate se non del tutto ignorate – l’A. si domanda se una tale invenzione del terzo settore possa ritenersi utile e produttiva, sia in termini di conoscenza che di operatività. La sua risposta è negativa.

Secondo Moro, il peccato originale sta nella definizione negativa del settore non profit il quale viene individuato soprattutto per quello che non è anziché per quello che è. Dei sette criteri elencati dai ricercatori, quattro sono chiaramente negativi. Degli altri tre, uno solo (la presenza di volontari) ha un significato pregnante e costituisce un effettivo elemento differenziale. Nel caso dell’Italia, il censimento dell’Istat riferito al 1999 rivela che il 20% delle organizzazioni non profit non hanno volontari mentre, all’opposto, soltanto il 16% delle organizzazioni di volontariato sono composte esclusivamente da volontari. Nelle definizioni ufficiali, che sono alla base delle rilevazioni statistiche, la presenza del personale volontario si è dunque volatilizzata.
Merita poi notare che la definizione del non profit ha un carattere prettamente economico. Il comparto è rilevante perché contribuisce in modo significativo alla formazione del Pil, tant’è che l’Istat definisce come organizzazioni non profit “tutte quelle realtà istituzionali, produttive di beni e servizi, anche prive di personalità giuridica, che non distribuiscono profitti ai soggetti costituenti”. E però nel momento in cui, in tutto il mondo, si cercano misure di valutazione del benessere che vadano “oltre il Pil”, il non profit è invece considerato rilevante proprio perché può farlo aumentare.
L’architettura concettuale del non profit è ispirata dal welfare all’americana dove lo Stato ha un ruolo secondario e residuale. Non è un caso che la spesa pubblica per il welfare sia del 13% in Usa, del 23% in Germania e Italia e del 29% in Francia. Negli Usa la maggior parte delle prestazioni educative, sociali, sanitarie, previdenziali e pensionistiche sono assicurate dalla comunità, non dallo Stato, attraverso un sistema di defiscalizzazione dei contributi. Ma una buona parte del mondo è organizzata in modo diverso: è lo Stato a garantire il benessere dei cittadini e l’accesso ai servizi è una garanzia universale.
Un’altra criticità generale è quella che Moro chiama “ideologia del capitale sociale” e secondo la quale il fatto che le persone si mettano insieme ha un valore in sé. L’affermazione del valore sociale dell’associazionismo è tutta da discutere, essendo molto più importante per che cosa ci si mette assieme e che cosa si fa. C’è una differenza notevole, anche in termini di valore sociale, tra un ristorante che ha la forma giuridica di un’associazione e una mensa per i poveri.
L’A. passa poi ai problemi più tecnici. Un caso è quello della confusione tra il tipo di soggetto e il tipo di attività che viene realizzata. Le università, gli ospedali, i partiti politici, le fondazioni sono chiaramente identificati per la loro struttura e la loro forma. Per altre organizzazioni invece vale il campo di attività (assistenza abitativa, protezione animali). Ci sono quindi due criteri concorrenti che convivono nella medesima classificazione.
Che il non profit abbia meritato attenzione e supporto da parte della collettività è potuto avvenire grazie ad un effetto alone. Alcune organizzazioni dimostratesi fruttuose hanno proiettato questa immagine positiva su tutto l’insieme. La parte cioè ha dato significato al tutto. L’effetto alone si è innescato anche grazie ad una serie di significati che a questo insieme è stato attribuito: gratuità e altruismo, coesione sociale ed economia “buona”.
Il primo è considerato essenziale per le organizzazioni non profit, però ad esempio i numeri del volontariato devono essere attentamente considerati. L’Istat definisce il volontario come “colui che presta la propria opera, anche saltuaria, senza ricevere alcun corrispettivo, presso l’istituzione non profit”. Ma quanto è saltuario? Alcune ore alla settimana, un giorno al mese, una volta l’anno? Inutile dire che ciò genera incertezza.
Il secondo elemento è quello della coesione sociale tra i gruppi e gli individui nella società. Mentre alcune attività hanno una evidente e diretta incidenza sul risultato della coesione (ad esempio quelle che riguardano i migranti) nel caso di molte altre questo nesso è debole o inesistente, tanto che nel discorso pubblico la coesione sociale viene tradotta (o ridotta) in termini di relazioni tra le persone che il non profit garantisce.
Questo slittamento semantico riporta al tema del capitale sociale e a quello correlato dei beni relazionali. Il capitale sociale non è buono in sé : lo è se contribuisce a migliorare la qualità della vita e a rompere l’isolamento delle persone; ma non lo è se crea gruppi chiusi, aggressivi verso l’esterno e dispotici verso l’interno. Gli studiosi al riguardo distinguono tra capitale sociale bridging (che crea ponti) e capitale sociale bonding (che crea recinti). Nel magma del non profit ci sono entrambi e sarebbe quindi il caso di usare con più discernimento questa categoria.
Connesso al capitale sociale risulta il tema dei beni relazionali. Secondo questa tesi l’universo delle organizzazioni non profit si qualifica per il fatto che produce dei beni che si costruiscono nelle relazioni tra le persone e che possono essere fruiti solo in tale relazione. La tesi coglie appieno una caratteristica fondamentale di esperienze come quelle delle comunità terapeutiche, dei consultori e delle case famiglia, ma in altri casi i beni relazionali sono minori o mancano del tutto.
Infine, il settore non profit è rappresentato come quello della “buona” economia con varie denominazioni: economia civile, impresa sociale, impresa solidale, economia fraterna o del dono. E’ l’immagine generalizzata di una economia buona perché persegue solo vantaggi sociali contrapposta alla economia cattiva delle imprese private che invece persegue il profitto a tutti i costi.
Nel capitolo dedicato alle contraddizioni e ai paradossi della situazione italiana, Moro parla di “come farsi male da soli”. L’eccezionalismo italiano si basa sulla convinzione che il non profit sia stato inventato in Italia molti secoli fa e che questo dia un primato al nostro paese. A sostegno di questa primogenitura viene spesso citata la fondazione, avvenuta nel 1244 per iniziativa del frate Pietro da Verona, della arciconfraternita della Misericordia, dedicata all’assistenza di malati e bisognosi, esistente ancora oggi. Questa tendenza all’associarsi sarebbe quindi caratteristica dell’umanesimo italiano e della civiltà cittadina di quel periodo. Ma Moro parla di organizzazioni che sono nate in buona parte nell’ultimo quarto del secolo scorso. Stabilire una continuità con il Medioevo è quantomeno temerario, come dimostrano le tante critiche che sono state rivolte alla teoria di Robert Putnam secondo cui le differenze nella civicness tra nord e sud d’Italia vanno cercate proprio nei comuni medioevali.
A prescindere da questi aspetti storici, il primo punto da evidenziare è il fatto che in Italia la legislazione sul settore non profit è una specie di marasma normativo nel quale spicca la legislazione fiscale con il Tuir (Dpr 917/86) e la c.d. legge Zamagni (Dl 460/1997). Gli enti non profit godono di un regime fiscale di favore. La common law britannica attribuisce lo status di charity a qualunque tipo di organizzazione in base alle finalità e all’attività che svolge per realizzarla. C’è stato un tentativo di trapianto in Italia del principio britannico ma non sembra aver funzionato, in primis perché la legge privilegia solo requisiti che rientrano nel tradizionale formalismo giuridico, tant’è che i controlli sono previsti sui bilanci non sul tipo di attività o sulla sua effettiva utilità sociale. Inoltre, certi enti sono riconosciuti come Onlus a prescindere da quello che fanno (sono Onlus di diritto). Infine, l’elenco delle attività che una organizzazione deve svolgere per essere riconosciuta come Onlus ha un evidente sapore assistenzialistico e un po’ arcaico. Moro crede che sia dovuto anche a questa concezione obsoleta se le leggi sul non profit sono oggetto di frequenti controversie e interpretazioni contrapposte. L’Agenzia “per le Onlus” era stata costituita nel 2002 e nel 2011 il suo nome fu modificato in Agenzia “per il terzo settore” ma un anno dopo è stata sciolta e le sue funzioni riassorbite dal Ministero del Welfare. Tra l’altro, era rilevante la confusione e l’incertezza dei ruoli tra questa Agenzia e quella delle entrate.
In questo quadro, già sufficientemente tribolato, è stata istituita la nuova figura dell’impresa sociale (Dl 155/2006): un’impresa privata in cui l’attività economica ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale (assistenza, educazione, istruzione, formazione, etc). Possono acquisire questo status associazioni riconosciute e no, fondazioni, comitati, società, cooperative, consorzi e inoltre organizzazioni che inseriscono lavoratori disabili e svantaggiati per almeno il 30% del personale. La introduzione della figura giuridica dell’impresa sociale non sembra all’A. che abbia aiutato a semplificare o a rendere più chiara la realtà del non profit in Italia e la sua gestione.
L’atteggiamento della pubblica amministrazione italiana nei confronti del settore non profit è contraddittorio: da un lato si dà fiducia e dall’altro la si toglie. Esempi di questo atteggiamento ondivago sono due provvedimenti definiti di sussidiarietà fiscale assunti negli ultimi anni: il 5 per mille e il meccanismo noto come “Più dai meno versi”. Il primo è stato introdotto con la legge finanziaria del 2006 ed ha incontrato un grande favore. Nel 2010 ne hanno usufruito 41.000 enti che hanno ricevuto 460 milioni di euro di cui 270 milioni sono andati alle Onlus e associazioni di promozione sociale. Il secondo strumento è stato introdotto dalla legge n.80 del 2005 e prevede che le donazioni in denaro o in natura erogate da persone fisiche o giuridiche in favore di Onlus siano deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70 mila euro l’anno. Nel 2012, l’art.15 della legge n.96 ha parificato i soggetti non profit ai partiti per le donazioni in denaro considerandole detraibili dall’imposta lorda sul reddito.
L’impressione che si ricava da questa panoramica è che nel comparto non profit del nostro paese non si è fatto molto per fare chiarezza. Si potrebbe fare di più e meglio. Moro pensa a una risorsa come le 88 fondazioni di origine bancaria create per legge alla fine degli anni ’90 per raccogliere e gestire la eredità di intervento filantropico delle casse di risparmio. Nel 2012 le fondazioni hanno erogato quasi un miliardo di euro per arte, attività e beni culturali (31,6%), per educazione-istruzione-formazione (15%) e così via. Ma anche qui c’è ambivalenza. Si possono trovare fondazioni che investono nello sviluppo del paese e altre che hanno semplicemente aggiornato le pratiche di distribuzione a pioggia di contributi, tipiche delle vecchie casse di risparmio.
Come anni fa era di moda accogliere con ingenuo stupore qualunque evento venisse realizzato da una organizzazione non profit, oggi la moda sembra opposta: mostrare sospetto e sfiducia mettendo in evidenza le malefatte di queste strutture. Come era fuori luogo l’entusiasmo così è sbagliata la diffidenza. Se il difetto genetico sta nella teoria sottostante al terzo settore, all’A. appare legittimo parlare di conseguenze non volute.
Sui comportamenti ingiusti ma legali, un caso dibattuto è quello del rapporto tra quanto viene raccolto e quanto viene effettivamente speso per i fini statutari. Altrove c’è un vincolo a spendere non più del 30% di quanto si raccoglie per sostenere la struttura. In Italia invece questo vincolo non c’è. Un altro caso è quello dei conflitti di interesse, con esempi ripetuti di dirigenti che costituiscono società private che a loro volta diventano fornitori delle organizzazioni non profit da loro dirette. Si sprecano poi le fattispecie di non profit che finanziano i partiti in modo perfettamente legale aggirando le norme sulla trasparenza dei finanziamenti per la politica (dark money politics).
Una seconda conseguenza non voluta è la concorrenza sleale che può crearsi tra enti non profit e imprese private o addirittura all’interno del terzo settore. In Italia ci sono tante palestre che formalmente sono non profit ma del cui valore sociale non si vede ombra: ma se queste entità agiscono come imprese, perché non devono pagare le imposte come imprese? Ancora, ci sono ristoranti che chiedono, prima di entrare, di iscriversi all’associazione che gestisce quell’esercizio in quanto riservato solo ai propri soci, cosicché tutti i clienti devono essere trasformati d’incanto in membri dell’associazione.
Moro trova poi inquietante la concorrenza per la raccolta fondi che è divenuto un vero e proprio mercato equivalente al Pil della quinta potenza industriale del mondo. Sul fronte della cooperazione internazionale è stato coniato il termine “interventismo selvaggio” per denotare comportamenti abnormi connessi alla competizione per le sovvenzioni. Ma la concorrenza riguarda anche l’acquisizione di visibilità, prestigio e influenza. Il caso delle 18 associazioni di consumatori italiane, riconosciute da una legge del 1998, è un tipico caso di alta conflittualità.
Un altro fenomeno che viene menzionato riguarda la prevalenza delle grandi organizzazioni, che hanno più mezzi per farsi valere in questa logica di mercatizzazione. E’ troppo retorico chiedersi se è questa la economia dal volto umano che si annuncia? Gli stessi meccanismi delle donazioni dal punto di vista fiscale (il 5 per mille, ad esempio) di fatto premiano le capacità di marketing sociale e chi ha le risorse per attivarle, non necessariamente la causa più giusta. E’ così che, quando si approssima la dichiarazione dei redditi, si apre la caccia ai Vip.
Un modo per negare che il non profit sia qualificato dalla presenza di volontari, il cui numero tende a diminuire, è quello di chiamare spesso a dirigere queste entità i manager delle imprese private. Per buona parte del terzo settore questo discorso ha poco senso, se non per la tendenza a livellare verso l’alto i livelli retributivi dei dirigenti. Su 30 dirigenti delle più grandi organizzazioni di cooperazione internazionale britanniche 19 hanno stipendi a sei zero; 30 su 100 top manager delle charity britanniche sono pagati più di 200.000 sterline l’anno e nove di essi più di 300.000; le due charity che pagano di più i propri dirigenti sono ospedali e strutture sanitarie. Il dibattito pubblico è naturalmente esploso: chi gestisce molti soldi deve essere pagato bene, dice la difesa, ma il pubblico ha espresso in larga maggioranza una opinione contraria: i soldi dei donatori vanno ai poveri e qualunque paragone con l’impresa privata è fuorviante. Questa mancanza di trasparenza e soprattutto di coerenza tra le attese dei donatori e la pratiche delle organizzazioni non profit è un problema di assoluto rilievo. Anche queste entità nell’ottenere la loro licenza sociale di operare non possono ignorare le aspettative del pubblico.
Tra le conseguenze non volute della invenzione del non profit c’è anche il suo lato oscuro (dark side). Si tratta di reati più o meno gravi ma comunque odiosi perché messi in atto sfruttando l’alone di benemerenza che ha accompagnato il terzo settore. Al riguardo Moro elenca una serie di casi che vanno dalle frodi ai danni dello Stato alle truffe ai danni dei donatori; dalla sottrazione di fondi alla struttura ai ricatti, estorsioni e altre attività illecite; dalle violenze, abusi e sfruttamento di soggetti in difficoltà alla violazione di standard di qualità e di sicurezza nella gestione dei servizi e così via. Il lato oscuro del terzo settore fa emergere con forza una questione generale: quella dei controlli sull’attività delle organizzazioni non profit.
Moro pensa che la situazione del terzo settore assomigli un po’ alla leggenda del Golem: un mostro buono, creato per proteggere la comunità, è diventato gigantesco e non sembra più rispondere a una logica coerente. Una parte rilevante di questo settore opera per evidenti finalità sociali, ma ciò non si può dire di tutto l’insieme in quanto mancano sia criteri chiari per stabilire ciò che è di effettiva utilità sociale, sia sistemi di controllo adeguati che garantiscano la coerenza dei comportamenti rispetto a questa “licenza sociale di operare”.
Il settore non profit conta in Italia oltre 300 mila istituzioni e organizzazioni (una per ogni duecento abitanti) che occupano a vario titolo quasi un milione di lavoratori (oltre a 4,7 milioni di volontari) e muovono qualcosa come 85 miliardi di euro, pari al 3,3% del Pil.
Negli Usa le istituzioni non profit sono stimate essere due milioni e 300.000 (più o meno la medesima proporzione dell’Italia quindi) ed un milione e 600.000 delle quali sono registrate ufficialmente come tali. Esse muovono circa 800 miliardi d
Ma se il non profit è diventato un gigante, come bisogna intervenire? Qualche anno fa il Parlamento italiano si era mosso con una proposta di legge per la costituzione di una commissione di inchiesta sul settore non profit, avanzata da una cinquantina di senatori, e di cui dal 2009 non si è saputo più nulla. Nel 2008 l’Agenzia delle entrate ha inviato 1.027 segnalazioni di Onlus irregolari su un totale di 300.000.
Nell’esercitare funzioni di controllo, il primo baluardo dovrebbe essere costituito dai consigli di amministrazione delle stesse organizzazioni non profit. Purtroppo in molti casi i consigli hanno fatto tutto il contrario: sono stati non solo complici ma pure beneficiari. In Italia è stato creato l’Istituto per la donazione, proprio allo scopo di favorire l’adozione di standard comuni di trasparenza e responsabilità. L’Istituto ha prodotto una Carta della donazione ed un marchio che si chiama “donare con fiducia” che opera attraverso un database dove vengono inserite informazioni sulle organizzazioni non profit che si iscrivono. Le informazioni riguardano la quota di finanziamenti destinati ai progetti rispetto a quelli utilizzati per la struttura della organizzazione. Ma il problema principale è che a questo Istituto sono iscritte e certificate con il marchio in tutto 60 organizzazioni. In pratica, qui da noi a controllare è rimasta solo l’Agenzia delle entrate.
La responsabilità è considerata di importanza decisiva per una buona gestione delle aziende e anche per risolvere molti dei problemi sollevati in questo libro: gli enti non profit rendono conto a qualcuno del proprio operato e della corretta amministrazione delle risorse. Ma verso chi questa accountability andrebbe esercitata? Verso i donatori, i beneficiari, lo Stato, i soci e i consigli di amministrazione, altre organizzazioni non profit, i media? Si tratta di un requisito sacrosanto e lo strumento principale dovrebbe essere il bilancio o rapporto sociale. Ma tale rapporto viene prodotto solo da una minoranza di enti. La proposta che circola in Italia è quella di prevedere per legge che tale documento venga prodotto da tutte le organizzazioni non profit. Non è difficile immaginare in questo caso un potente effetto imitativo analogo a quello verificatosi nel settore privato. Ma poi chi lo legge?
Responsabilità non significa solo riferire al pubblico quello che si è realizzato ma anche che il pubblico medesimo possa premiare o punire la organizzazione per quello che ha fatto o non ha fatto. In altri casi ci sono le elezioni o la sfiducia degli azionisti al management. Ma in questo caso? Certo i finanziatori possono ritirarsi dal sostegno, ma i beneficiari quale potere hanno su chi si occupa dei loro problemi? L’accountability è davvero ardua da realizzare. Insomma è bella in teoria ma in pratica è un po’ una leggenda.
L’allora presidente dell’Agenzia per le Onlus, Stefano Zamagni, proponeva un meccanismo di finanziamento connesso all’obbligo per le organizzazioni non profit di pubblicare i bilanci e al divieto di spendere per alimentare la propria struttura più del 30% di quanto raccolto. Egli rilanciava anche l’idea di creare una borsa sociale attraverso la quale emettere “bond della solidarietà” per finanziare progetti di utilità sociale. La spending review purtroppo non ha permesso di vedere all’opera questa proposta.
Anche se, per avventura, fosse possibile esercitare controlli su tutte le organizzazioni non profit, in che modo ciò potrebbe avvenire? E quali dovrebbero essere i criteri di valutazione? Purtroppo la maggior parte dei controlli vengono realizzati sulla carta e hanno per oggetto la regolarità formale degli statuti e degli atti delle organizzazioni. Il problema è che non vengono prese in considerazione le attività svolte e tantomeno i risultati raggiunti.
E allora, che cosa andrebbe fatto? Il libro non ha l’intento di avanzare proposte, ma solo di sollevare un problema ed offrire alcuni spunti di riflessione sul da farsi. In primis, la soluzione del problema deve essere affidata ad un dibattito approfondito da svolgere nell’arena pubblica. Il secondo punto è che la situazione attuale non è il frutto di una cattiva attuazione di una buona idea, é piuttosto il frutto di una cattiva idea che si è incarnata in comportamenti coerenti con essa; quindi é proprio il sistema che va ripensato. Il terzo punto è che bisogna distinguere nettamente e accuratamente tra il versante cognitivo e quello normativo della questione.
Il fatto che nel mondo ci siano entità che non sono né statali né imprenditoriali non autorizza a tenerle tutte insieme dando ad esse un significato unitario. Moro crede che si debba decostruire il magma del non profit enucleando realtà differenti tra loro e raggruppando quelle che sono ragionevolmente omogenee agli occhi del pubblico. Egli crede di potersi esercitare effettuando sette raggruppamenti: imprese, enti quasi pubblici, organizzazioni della produzione e del lavoro, istituzioni di supporto, enti di ricerca, organizzazioni del capitale sociale.
La prima categoria è quella di entità che hanno una normale attività economica o di impresa ma che hanno assunto lo status di non profit per ragioni di convenienza legale o fiscale: bar, ristoranti, palestre, gallerie d’arte, scuole, università, strutture sanitarie e servizi sociali. Il fatto che alcune di queste strutture siano meritevoli di sostegno pubblico ha a che fare con il modo di trattare tali organizzazioni non con la loro identificazione. Il secondo tipo di entità sono quelle quasi-pubbliche o parapubbliche, come gli enti lirici o altre istituzioni artistiche che lo Stato ha ritenuto di trasformare, ma anche il Coni e la Croce Rossa, le fondazioni culturali e quelle bancarie. Ci sono poi le istituzioni che per comodità si possono definire come appartenenti al modello corporativo: associazioni imprenditoriali e professionali, sindacati dei lavoratori, fondi pensioni, patronati, ecc. Una quarta “cosa” sono gli enti e le istituzioni che operano a supporto di programmi e attività di utilità sociale realizzate da cittadini, cioè fondazioni e altre istituzioni grant-making ma anche entità che mettono a disposizione conoscenze, informazioni, know-how. In una categoria a parte egli colloca le organizzazioni che si occupano di ricerca nel campo medico, i centri di ricerca o i think tank. Alcune entità possono definirsi come organizzazioni del capitale sociale perché rafforzano i legami sociali, la condivisione e il dialogo: associazioni musicali o di gioco, comunità religiose, gruppi di vicinato, sport per bambini e ragazzi. Infine ci sono le organizzazioni di attivismo civico che coinvolgono i cittadini nell’attuazione diretta di norme di rango costituzionale attinenti ai diritti della persona o alla cura di beni comuni della più alta rilevanza. E i partiti dove si mettono? Una opinione crescente tende a collocarli nel primo settore, cioè nello Stato, anziché nel terzo.
In un mondo in cui i confini sembrano diluirsi o sparire del tutto, appare sempre meno chiaro qual è l’ambito operativo pubblico e quale quello privato. Nel magma del terzo settore si trovano variamente mescolati elementi che tradizionalmente sono attribuiti alla mission dello Stato ed altri che sono tipici dell’imprenditorialità privata ed altri ancora che sono usualmente catalogati sotto il pur ambiguo concetto di “società civile”.
Da molti il welfare è considerato l’unico luogo in cui il non profit opera, forse perché è quello in cui girano più soldi. L’alternativa al terzo settore non è per Moro un welfare statale o peggio statalista, nel quale i cittadini pagano molte tasse e ottengono servizi scadenti. Da noi il non profit che opera nel welfare è di fatto largamente finanziato dallo Stato anziché dalla comunità. Qui è lo Stato che è responsabile del benessere dei cittadini e gestisce il welfare o direttamente o delegandolo a soggetti esterni sulla base di standard da esso fissati.
E’ il momento di domandarsi dove sta il valore sociale in queste strutture. Esso sta esclusivamente nelle cose che fanno, come le fanno e soprattutto negli effetti che conseguono nella realtà. E’ di utilità sociale l’assistenza domiciliare ai malati terminali? Certamente sì. Lo è un centro fitness? No, di certo. Naturalmente l’utilità sociale dell’attività dovrebbe essere considerata in termini di grado e non in termini assoluti: un servizio di accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza è di massima utilità sociale; una festa di vicinato lo è di meno; un circolo di tennis o di canottaggio per ricchi lo è poco o per nulla. Insomma, le attività svolte sono l’unico punto di riferimento disponibile per stabilire “ciò che è bene”.
Il grado di valore sociale espresso da queste entità deve essere necessariamente definito in riferimento a un criterio valido e accettabile per tutti, cioè quello dell’interesse generale. Ma che cos’è l’interesse generale? Chi lo stabilisce? La risposta non è facile ed è necessariamente articolata. Secondo Moro, è di interesse generale: ciò che lo Stato definisce tale nella Costituzione e nelle leggi; le fattispecie riconosciute da dichiarazioni e documenti internazionali che riguardano i diritti umani o fondamentali; ciò che è riconosciuto come tale nell’arena pubblica e nei processi di deliberazione che coinvolgono la comunità politica. A queste risposte vanno aggiunti due importanti corollari. Il primo è che l’interesse generale non è fisso ma cambia nel tempo, in relazione a mutamenti nei significati sociali e nei sistemi di valori. Il secondo è che la definizione dell’interesse generale è una materia altamente conflittuale che è al centro della lotta politica della quale sono protagonisti non solo i partiti ma l’intera comunità. In aggiunta o in alternativa all’interesse generale si potrebbe utilizzare il principio di solidarietà esplicitamente indicato nella nostra Costituzione come dovere inderogabile.
In ultima analisi, secondo Moro il settore non profit non è uno scandalo però, insieme a molte esperienze positive e benemerite, annovera patologie che non vanno nascoste né sottovalutate. Se prima non era da santificare, ora non si può sic et simpliciter condannarlo. E’ composto di persone molto diverse tra loro per motivazioni, aspettative e modi di operare, così come lo sono le organizzazioni erroneamente poste sotto questa etichetta. Il problema quindi non è quello di incensare o condannare ma quello di esaminare, capire e operare di conseguenza. Capire non è facile ma proprio per questo è necessario. Ignorare che molti aspetti sono da correggere non è un modo di superare il problema ma solo di allontanarlo per ritrovarselo davanti al prossimo incrocio.
(Lorenzo Paliotta)